MANUALE PER IL CENSIMENTO FLORISTICO DELLA LOMBARDIA
ZURLI M. (**), ROSSI G. (**), GALASSO G. (*)
e VIRGA M. (**)
(*) REGIONE LOMBARDIA
(**)
DIPARTIMENTO DI ECOLOGIA DEL TERRITORIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PAVIA
INDICE (versione del 19 Novembre 2001)
1.
ELEMENTI DI
TOPOGRAFIA
1.1. La forma della Terra
e il reticolato geografico
1.2.
Determinazione della posizione assoluta e le coordinate geografiche:
latitudine e longitudine
1.3. Le
coordinate sferiche e piane
1.4. Le carte
geografiche
1.5. Classificazione delle
carte
1.6. La Carta topografica
d’Italia
2.
LA
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE PIANTE
2.1. L’area di distribuzione
2.2. I principali geoelementi della flora lombarda
3.
IL CENSIMENTO
DELLA FLORA LOMBARDA E IL RETICOLO CARTOGRAFICO ADOTTATO
3.1. Generalità
3.2.
Note pratiche per il rilevamento in campo
3.3. Brevi istruzioni per l’uso della scheda di campo
(Gabriele Galasso)
3.4. Scheda di campo
per il rilevamento floristico
4.
BIBLIOGRAFIA e
INFORMAZIONI UTILI
1. M. Zurli - ELEMENTI DI TOPOGRAFIA
1.1. La forma della Terra e il reticolato geografico
I popoli antichi ebbero a lungo concezioni fantastiche ed
errate circa la vera forma della Terra. Oggi tutti sono a conoscenza della
sua
sfericità, ma probabilmente pochi saprebbero enunciare delle semplici prove.
Una di queste ci è data dall’osservazione del mare: infatti man mano che una
nave si allontana sembra affondare lentamente al di sotto del livello
dell’acqua. La spiegazione risiede nel fatto che la superficie del mare è
curva. Le fotografie prese dai satelliti terrestri, ad altissime quote, ci
mostrano l’orizzonte come una linea curva.
In realtà la Terra non è
perfettamente sferica; esiste uno schiacciamento polare causato dalla forza
centrifuga della rotazione terrestre. È quindi possibile distinguere:
- un
asse;
- un Polo nord o boreale o artico, rivolto verso la Stella polare;
- un Polo sud o australe o antartico.
La Terra si immagina poi avvolta
dalla rete formata da circonferenze passanti per i poli e da circonferenze ad
esse perpendicolari; queste in complesso, costituiscono il reticolato
geografico, necessario per determinare la posizione assoluta di ogni punto.
Il piano perpendicolare all’asse e passante per il centro della Terra
determina sulla superficie terrestre una circonferenza massima che è
l’equatore, i cui punti sono egualmente distanti dai poli; esso quindi divide
la sfera in due emisferi, uno dei quali è l’emisfero settentrionale o
boreale,
l’altro l’emisfero meridionale o australe.
I paralleli sono circonferenze
minori, parallele all’equatore, poste a Nord e a Sud di esso.
I meridiani
sono semicirconferenze massime che hanno per estremi i poli e che tagliano ad
angolo retto l’equatore e i paralleli. Ogni meridiano è completato dalla
parte
opposta da un’altra semicirconferenza che è il suo antimeridiano: meridiano
ed
antimeridiano formano il circolo meridiano.
1.2. Determinazione della posizione assoluta e le coordinate geografiche: latitudine e longitudine
La latitudine è la distanza di un punto dall’equatore,
espressa dall’arco di meridiano tra essi interposto e misurato in gradi e
frazioni di grado.
La longitudine è la distanza di un punto da un
meridiano preso come fondamentale (meridiano zero), espressa dall’arco di
parallelo tra essi interposto e misurato in gradi e frazioni di grado.
Dal
1884 il meridiano fondamentale internazionale è quello passante per
l’Osservatorio di Greenwich, vicino a Londra.
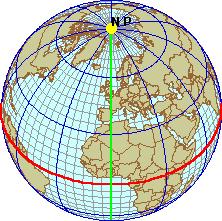
|
Fig. 1 – Meridiani e paralleli (da ESRI, www.esri.com) |
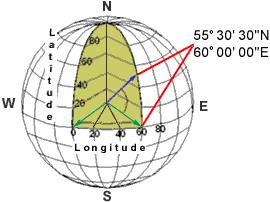
|
Fig. 2 – Latitudine e longitudine (da ESRI, www.esri.com). |
1.3. Le coordinate sferiche e piane
Latitudine e longitudine vengono definite dal geografo come
coordinate geografiche e il sistema dei meridiani e dei paralleli come
reticolato geografico. Le coordinate geografiche sono considerate coordinate
sferiche, in quanto designano la localizzazione dei punti sull’ellissoide di
rotazione precedentemente descritto.
I meridiani e i paralleli non sono
linee rette ed equidistanti ne formano un reticolo di questo tipo su alcuna
delle proiezioni cartografiche di largo uso. Da qui la necessità di
introdurre
un sistema completamente diverso, quello delle coordinate piane (o
cartografiche o metriche), al fine di poter usufruire nelle carte di un
reticolato ortogonale ed equidistante.
Le coordinate piane, indicate Est e
Nord, sono in sostanza coordinate cartesiane dove l’ascissa è costituita
dall’equatore e l’ordinata dal meridiano centrale del fuso a cui appartiene
la
zona rappresentata sulla carta. Infatti, per evitare forti deformazioni sul
piano della carta, la superficie terrestre viene suddivisa in "spicchi" detti
fusi, dell’ampiezza di 6° di longitudine.
Il sistema di coordinate piane
oggi maggiormente usato nel mondo è il reticolato chilometrico, che si
riferisce alla proiezione universale trasversa di Mercatore (U.T.M.).
Le zone del reticolato chilometrico
Le coordinate
chilometriche nell’ambito di piccole aree appartengono ad una ben definita
zona del reticolato. Un sistema internazionale suddivide l’intero globo in
zone.
Il reticolato della proiezione universale trasversa di Mercatore,
indicato come sistema U.T.M., consiste di 60 "spicchi" detti fusi, ciascuno
della larghezza di 6° di longitudine, numerati da 1 a 60 a partire
dall’antimeridiano di Greenwich e procedendo verso E.
20 fasce
dell’ampiezza di 8° di latitudine e indicate con lettere maiuscole.
I
quadrangoli risultanti dall’intersezione fra un fuso ed una fascia sono detti
zone e designati con il numero del fuso seguito dalla lettera della fascia.
L’Italia si trova nei fusi 32 e 33 e nella fascia S e T; quindi risulta
suddivisa nelle zone 32T, 32S, 33T, 33S.
1.4. Le carte geografiche
Poiché la Terra ha forma sferoidale, il sistema più esatto
per rappresentarla è quello di costruire dei globi. I globi sono le uniche
rappresentazioni fedeli della Terra. Ma questi globi, per essere maneggevoli,
debbono essere di piccole dimensioni e in tal caso non possono rappresentare
che i tratti principali della Terra.
Per lo studio particolareggiato della
Terra si adoperano le carte geografiche, che rappresentano la superficie
terrestre o una sua parte riportandola su un piano.
Possiamo definire la
carta come una rappresentazione:
- ridotta, non essendo possibile
mantenere nella carta le distanze e le superfici reali.
La scala di
riduzione è una delle caratteristiche più importanti della carta, ed è data
dal rapporto tra una lunghezza misurata sulla carta e la lunghezza ad essa
corrispondente sul terreno.
- approssimata, non essendo possibile
riportare la superficie di una sfera su un piano.
I procedimenti di una
regola geometrica per tracciare nel piano il reticolato dei meridiani e dei
paralleli della sfera, costituiscono, in vari modi, le proiezioni
geografiche.
- simbolica.
Le carte geografiche utilizzano simboli per rappresentare
a d esempio oggetti, ma anche i rilievi (mediante le curve di livello o
isoipse, linee che uniscono i punti della superficie terrestre a eguale
quota).
1.5. Classificazione delle carte
Le carte in base alla scale si possono classificare in (Mori,
1990):
- carte con grandissima scala (inferiore a 1:10.000);
- carte
con grande scala, compresa tra 1:10.000 e 1:200.000, dette carte
topografiche;
- carte con scala media, compresa tra 1:200.000 e 1:1.000.000, dette carte
corografiche;
- carte con scale piccole (maggiore di 1:1.000.000), dette
propriamente carte geografiche.
Ricordiamo l’esistenza di carte tematiche,
che rappresentano principalmente su base geografica o topografica dei temi
(natura del suolo, elementi climatici, distribuzione della vegetazione,
densità della popolazione, distribuzione delle singole colture, ecc.).
1.6. La Carta topografica d’Italia
La Carta topografica d’Italia, la cui costruzione è affidata
all’Istituto Geografico Militare (I.G.M.), alla scala 1:100.000 consta oggi
di
285 fogli. Ad ogni foglio al 100.000 corrispondono quattro carte al 50.000,
chiamate quadranti, che si indicano col numero del foglio e con un numero
romano (da I a IV) secondo il posto che essi occupano nel foglio stesso,
andando nel senso delle lancette dell’orologio.
A sua volta ogni quadrante
comprende quattro carte al 25.000, chiamate tavolette, ciascuna delle quali,
oltre che con un nome, si indica col numero del foglio e del quadrante di cui
fa parte, cui fa seguito il segno del punto cardinale in cui si trova nel
quadrante stesso (fig. 3).
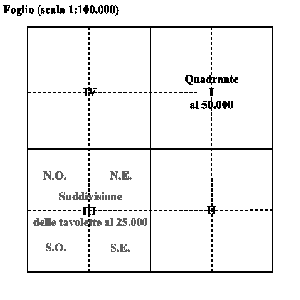
|
Fig. 3 – Suddivisione di un foglio della Carta topografica d’Italia in quadranti al 50.000 e in tavolette e modo per indicarli. |
Ricordiamo inoltre l’esistenza di una cartografia realizzata
dalle regioni alla scala 1:10000 e 1:5000, denominata Carta Tecnica Regionale
(C.T.R.) e suddivisa in Sezioni. Per la Regione Lombardia è attualmente
disponibile la C.T.R. alla scala 1:10000.
2. LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE PIANTE
2.1. L’area di distribuzione
Areali
La distribuzione geografica di una specie (o un
genere, una famiglia, ecc.) viene definita dal suo areale. Per areale si
intende la parte di superficie terrestre in cui la specie è presente in
condizioni di spontaneità e in modo stabile.
Una distinzione può essere
fatta tra areale geografico e areale regionale: il primo si riferisce
all’intera distribuzione, il secondo si riferisce alla distribuzione
nell’ambito di un territorio prefissato. Quando si parla di areale senza
alcuna specificazione, si intende areale geografico.
La rappresentazione
di un areale viene fatta su base cartografica: attualmente il metodo più
diffuso è quello della rappresentazione su reticolo geografico,
contrassegnando le maglie nelle quali si trova almeno una stazione della
specie in esame. La raccolta di informazioni sulla distribuzione geografica
di
una specie, quando non ancora perfettamente nota, inizia ovviamente dalle
osservazioni di campagna. L’informazione elementare è data dalla
constatazione
della presenza di una specie in un determinato punto del territorio, una
stazione, che può essere definito con precisione da coordinate. A tal fine,
attualmente, si possono utilizzare i G.P.S. ossia sistemi di posizionamento
geografico, strumenti ormai alla portata di tutti (anche se con differente
grado di precisione), che utilizzano per il posizionamento del punto le
informazioni satellitari.
I limiti di distribuzione di una specie vanno
cercati innanzitutto nelle condizioni climatiche avverse dei territori
circostanti: ad esempio le piante mediterranee sono bloccate verso nord dal
freddo dell’inverno e verso sud dall’aridità del Sahara. Gli areali non
coincidono però necessariamente con definiti tipi di clima: esistono infatti
specie altamente tolleranti con areali molto vasti che comprendono differenti
situazioni climatiche, anche se spesso una vasta distribuzione si spiega con
una diversa collocazione altitudinale.
I limiti di una distribuzione vanno
ricercati anche in cause non strettamente climatiche, come il tipo di
substrato, la distribuzione di fitofagi e patogeni, la distribuzione degli
animali dispersori di semi e frutti e impollinatori.
Spesso gli areali
sono delimitati da barriere geografiche che la specie non riesce a valicare,
come oceani, grandi deserti o catene montuose. L’insieme dei territori che
una
specie potrebbe occupare se non esistessero barriere geomorfologiche è
definito areale potenziale.
Se tutti i punti disegnati sulla carta che
descrive la distribuzione di una specie risultano molto vicini tra loro, così
da poter essere rappresentati da un’unica area, si parla di areale continuo.
Se invece è possibile circoscrivere due o più regioni di distribuzione si
dice
che l’areale è disgiunto e costituito da areali parziali. Quando queste
superfici sono molto piccole, al limite di una singola stazione, si
parla di areale relitto e la popolazione relativa viene definita relitto
geografico. Le situazioni disgiuntive sono molto importanti in quanto
favoriscono la formazione di nuove specie per evoluzione graduale ed
indipendente, con fasi intermedie di rango sottospecifico: non è un caso che
gli areali parziali di una specie siano spesso occupati da entità
sottospecifiche differenti (vicarianza geografica). Quando a differenza
distributiva si accompagnano anche variazioni morfologiche e genetiche
significative è possibile distinguere entità specifiche ben separate.
La
dimensione degli areali è molto varia: gli estremi opposti sono dati da
areali
molto piccoli e da areali molto grandi che si estendono su più continenti.
Per
questi casi estremi si parla rispettivamente di specie stenoendemiche e di
specie cosmopolite, dove per steno- si intende "stretto" (opposto ad euri- o
ampio). Il termine endemico, come tale, indica un taxon (cioè organismi
considerati ad un qualsiasi livello tassonomico: specie, genere, famiglia,
ecc.) che presenta distribuzione geografica esclusivamente limitata ad un
dato
territorio. Di conseguenza si può indicare come endemico anche un taxon
dall’areale vasto: ad esempio si può parlare di "endemico italiano" o di
"endemico europeo", ecc. Infine va precisato che è preferibile usare il
termine endemismo per indicare il fenomeno che produce taxa (plurale di
taxon)
ad areale limitato, mentre col termine endemita si è soliti indicare il tipo
di endemismo (es. endemiti alpici, endemiti lombardi, ecc.).
All’interno
di un areale, la densità specifica è definita come il numero di individui per
superficie: essa è tanto più elevata quanto migliori sono le condizioni
ecologiche per la specie presa in esame, mentre diminuisce drasticamente
allorquando almeno uno dei fattori ambientali si avvicina al minimo o al
massimo valore tollerabile dalla specie.
2.2. I principali geoelementi della flora lombarda
In relazione alla localizzazione geografica degli areali e
alla posizione dei centri di differenziazione, le diverse specie possono
essere riunite in geoelementi, di cui i principali per la nostra flora sono:
insubrico, sudest-alpico, alpico, artico-alpino, europeo, mediterraneo e
cosmopolita. Ogni geoelemento raggruppa quindi specie con aree di
distribuzione più o meno sovrapposte e la presenza di centri di
differenziazione dimostra la zona in cui attualmente una specie trova le sue
migliori condizioni di vita.
Con le sue oltre 7.000 specie la flora
d’Italia è tra le più ricche d’Europa. Questo primato dipende dalla sua
storia
biogeografica e dalla disponibilità di ambienti diversi offerti dal
territorio (l’Italia appartiene infatti a due regioni fitogeografiche: quella
mediterranea e quella eurosiberiana), ma anche dal modo col quale i
sistematici delimitano le specie.
Tra gli endemiti italiani vi sono specie
assai localizzate, ma anche specie ben più comuni se non ampiamente
distribuite. Come esempi per la Lombardia, per le prime, si può citare
Primula
glaucescens con areale limitato ad un territorio molto ristretto, tra i laghi
di Como e Garda, oppure Moehringia markgrafii per una o due stazioni in valle
Sabbia; per le seconde Sesleria shaerocephala endemita SE-alpico. Le aree più
ricche di steno-endemiti locali sono: Alpi Giulie, Prealpi lombarde e venete,
Alpi Apuane, Etna, Gennargentu. Le aree più povere corrispondono soprattutto
alle pianure alluvionali recenti, ma non solo a queste: pianura
padano-veneta,
Alpi Aurine Appennino settentrionale, pianura campana, Tavoliere e Murge.
La flora è l’elencazione delle specie che si trovano in un territorio ben
delimitato, corredata di tutte le informazioni necessarie per definire la
distribuzione e l’ecologia di ogni specie. Le flore regionali, come quella
della Lombardia, si costruiscono attraverso la convergenza di tante flore
locali, studiate anche in tempi diversi.
Gli endemiti assumono particolare
risalto in una flora locale o regionale: siano esse esclusive o presenti in
aree limitate e disgiunte da altre lontane, sono testimoni di evoluzioni
recenti del gruppo di specie cui appartengono (neoendemiti) o delle
variazioni
storiche subite dalle aree di distribuzione originarie (paleoendemiti).
Analizzare una flora raggruppandone le specie in geoelementi dà diversi
vantaggi: prima di tutto si può giustificare, sia sul piano storico sia su
quello ecologico, la presenza di specie poco diffuse, quindi se ne può
valutare l’importanza ai fini conservazionistici.
I principali geoelementi
della flora lombarda sono:
-
Specie orofite
centro-sudeuropee
: distribuzione che interessa le Alpi e le altre
catene europee (Pirenei, Carpazi, ecc.). Tra le comuni si possono ricordare
Nardus stricta, Rhododendron ferrugineum, Carex foetida, Leucanthemopsis
alpina.
- Specie artico-alpine: specie presenti nelle regioni artiche e
sulle alte montagne della zona temperata, dove occupano ambienti freddi ad
altitudini elevate; questi habitat rappresentano relitti di vegetazione che
si
insediò nel corso di periodi glaciali passati. Tra queste specie si possono
citare Salix herbacea, Silene suecica (=Lychnis alpina) e Empetrum
hermaphroditum.
-
Specie circumboreali
: specie
ad ampia diffusione ma con notevole discontinuità, tanto da estendersi per
gran parte dell’emisfero boreale. Tra queste si possono citare le ericacee
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea e Calluna vulgaris; nelle torbiere
Eriophorum angustifolium e Juncus alpinoarticulatus e tra le felci
Cryptogramma crispa. Proprio in seguito alla rarefazione delle loro stazioni
alcune specie circumboreali possono essere considerate rare a livello locale,
come nel caso dell'orchidea Goodyera repens.
-
Endemiti alpici
: nella flora lombarda si può riconoscere
un numero elevato di specie molto frequenti, ma esclusive dell’intera catena
alpina. Tra queste si possono ricordare: Cirsium spinosissimum e Festuca
melanopsis (in Pignatti 1982 indicata come F. puccinellii). Altre assumono
maggiore spicco a causa di una distribuzione più limitata: Campanula cenisia
e
Primula daonensis.
-
Endemiti alpici
sud-orientali
: si possono ricordare come esempi Carex baldensis, Allium
insubricum, Saxifraga presolanensis, Campanula raineri, Primula glaucescens,
Galium montis-arerae, nonché altre specie esclusivamente lombarde come Viola
comollia o Sanguisorba dodecandra.
L’interesse scientifico per queste
specie è giustificato dal fatto che con la ricostruzione delle contrazioni
degli areali (paleoendemiti) o delle nuove comparse (neoendemiti), si possono
fare ipotesi sulla storia naturale del territorio alpino cui si unisce la
storia delle specie stesse, legate spesso alle vicende umane.
In
bibliografia vengono riportati diversi testi che è possibile consultare per
approfondimenti sulle questioni sopra trattate.
3. IL CENSIMENTO DELLA FLORA LOMBARDA E IL RETICOLO CARTOGRAFICO ADOTTATO
3.1. Generalità
Per flora si intende la lista delle specie che
complessivamente si trovano in un determinato territorio inteso come area
geografica, comprensiva di tutti gli aspetti geomorfologici e ambientali. La
flora esprime un significato sia storico, in quanto legato a vicissitudini di
tipo evoluzionistico, distributivo ed ambientale, sia ecologico, in quanto
legata ad aspetti climatici, orografici, ecc.
Per un’analisi accurata di
una flora occorre un censimento floristico; per censimento floristico si
intende il rilevamento in campo, la determinazione e la catalogazione della
flora di un dato territorio. I dati raccolti potranno quindi essere
confrontati con quelli storici, in modo da mettere in evidenza eventuali
cambiamenti.
La Regione Lombardia (sotto la responsabilità del dott.
Gabriele Galasso, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – Unità
Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi) ha recentemente
avviato un progetto per il censimento della flora spontanea dell’intero
territorio regionale al fine di realizzare un Atlante Corologico delle piante
vascolari, sul modello di diversi esempi già disponibili in nazioni vicine o
regioni e province italiane (cfr. bibliografia).
Questo progetto
regionale, in particolare, trova nei territori dei Parchi e delle altre zone
protette, le aree di maggiore interesse, vista l’alta biodiversità in specie
vegetali qui ospitate.
La distribuzione delle specie sarà rappresentata
mediante il reticolo cartografico adottato nella "Cartografia floristica
dell’Europa Centrale" (Ehrendorfer & Hamann, 1965). Secondo questo
sistema
la mappatura dei dati raccolti viene effettuata utilizzando un reticolo con
maglie predeterminate.
Il primo tipo di modulo previsto è denominato area
di base che ha una dimensione di 6' di latitudine x 10' di longitudine; esso
viene identificato da due coppie di numeri, la prima relativa alla riga e la
seconda alla colonna (es.: 9725 in fig. 4). Ciascuna area di base misura
circa
11 x 13 km di lato e viene individuata dalla località più importante,
presente
nell’area stessa.
Ogni area di base è divisa ulteriormente in 4 quadranti
(1 e 2 rispettivamente in alto a sinistra e a destra; 3 e 4 rispettivamente
in
basso a sinistra e a destra) (es.: 9725-3).
Il quadrante, di forma
rettangolare, è l’unità cartografica di riferimento e ad esso vengono
riferiti
i dati presenza\assenza di ogni specie. Le sue dimensioni lineari
corrispondono a circa 6 km x 5 km. Infine ogni quadrante viene suddiviso in 4
settori e ognuno di essi, a sua volta, in 4 sottosettori.
Il modo in cui
vengono raccolti i dati consente dunque una certa versatilità e in
particolare
permette di ricartografare i dati in una fase successiva con un reticolo a
maglie più fini o più larghe.
Il metodo si integra bene con il sistema
cartografico dell'IGM poiché ogni modulo, o area di base, corrisponde
esattamente a ¼ di carta alla scala 1:50000.
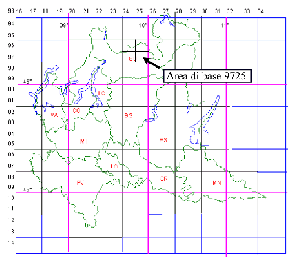
|
Fig. 4 – Reticolo formato dalle "area di base" della cartografia floristica in cui è possibile suddividere la Regione Lombardia. Ogni area di base può essere suddivisa in quattro quadranti, un quadrante in quattro settori e un settore in quattro sottosettori. |
3.2. Note pratiche per il rilevamento in campo
Uno dei problemi importanti nel rilevamento in campo è quello di conoscere con esattezza l’area di base, il quadrante, settore e sottosettore nel quale si sta operando. La Regione Lombardia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha realizzato una griglia, in formato shapefile, georiferita in modo tale da poter essere sovrapposta alla Carta Tecnica Regionale della Lombarda in formato raster mediante un semplice visualizzatore come ArcEsplorer della Esri (gratuito, scaricabile dal sito www.esri.com).
3.3. G. Galasso - Brevi istruzioni per l’uso della scheda di campo
La scheda di campagna che segue è stata realizzata secondo il
modello di rilevamento floristico elaborato da Ehrendorfer & Hamann
(1965). Di seguito si riportano brevemente alcune convenzioni redazionali
utilizzate nella sua preparazione. Innanzitutto, le diverse specie sono
riportate in ordine alfabetico, separando su diverse righe i nomi generici
(maiuscolo grassetto) e gli epiteti specifici o intraspecifici. Taxa
congenerici tra loro sistematicamente affini e/o simili (pertanto spesso
soggetti a rischi di confusione) ovvero afferenti alla medesima specie, sono
stati riuniti all’interno di "gruppi". Ciò perché il rilevatore, a seconda
della sua preparazione, degli strumenti che ha a disposizione o dell’attuale
stato delle conoscenze, possa segnalare la esatta specie, microspecie o
sottospecie ovvero possa limitarsi a una segnalazione più generica, ma
standardizzata (es Achillea gr. millefolium o Anthyllis gr. vulneraria). Per
gli epiteti delle specie "normali" è utilizzato il carattere minuscolo, per i
gruppi di specie il carattere grassetto, mentre per le suddivisioni dei
gruppi
il maiuscolo. In alcuni casi (Alchemilla gr. alpina, Alchemilla gr. vulgaris,
Callitriche sp., Cuscuta sp., Dryopteris gr. filix-mas, Rosa gr. canina e
Rubus gr. fruticosus) è stato previsto il gruppo di gruppo, indicato col
maiuscolo corsivo; soltanto per il genere Hieracium, che prevede gruppi di
gruppi e, nel caso di H. gr. murorum, una ulteriore categoria superiore, sono
stati impiegati formati differenti. Ovviamente, lo stesso schema
classificativo in gruppi (e loro eventuali suddivisioni) è seguito
dall’applicativo informatico per la Cartografia Floristica "ARC" (Atlante
Ricerca Corologica, in Access 2.0) realizzato dalla Regione Lombardia. Gli
epiteti o i nomi di gruppo riportati tra parentesi si riferiscono a specie le
cui segnalazioni per il territorio lombardo sono dubbie o da ricontrollare
ovvero per quelle non segnalate in Regione ma che è possibile ritrovare
poiché
presenti in zone limitrofe (es. Alopecurus aequalis, Achillea stricta subsp.
tanacetifolia, Brachypodium pinnatum); invece i nomi seguiti da punto di
domanda si riferiscono a taxa di dubbio valore sistematico (es. Achillea
millefolium subsp. sudetica).
Per la nomenclatura si è seguito Pignatti
(1982), tranne che per alcuni cambi di genere grammaticale (es. Rhamnus), per
alcune correzioni ortografiche (es. Artemisia verlotiorum) e per le entità
ivi
non riportate (es. Primula albenensis).
Nel caso di Hieracium subgen.
Pilosella si è condivisa l’impostazione seguita da Stace (1991) e da Brisse
& Kerguelén (1994), che considerano di origine ibrida i taxa
intermediari.
In genere, comunque, la scheda non riporta gli ibridi, anche perché
difficilmente riconoscibili sul campo, tranne nel caso di Hieracium (come
detto) e di quelli più comuni (es Mentha xpiperita e Salix xrubens).
Infine la scheda prevede appositi spazi per segnare il quadrante (numero
e/o nome convenzionale, con la possibilità di specificare la sua suddivisione
-settore e sottosettore-), il nome del rilevatore, la data, eventuali note,
eventuali specie aggiunte, la descrizione e articolazione del percorso. In
particolare, relativamente a quest’ultimo punto, è utile suddividere il
percorso in segmenti o tratti, individuati da numeri progressivi, per ognuno
dei quali indicare il Comune, la località e l’eventuale area protetta in cui
è
localizzata, l’intervallo altitudinale (quota minima e massima), il chimismo
e
l’esposizione.
Le segnalazioni vengono marcate sulla scheda sottolineando
il nome del taxon presente (scegliendo, come detto, tra gruppo o
"microspecie") e appuntando di fianco il numero relativo al segmento in cui
viene osservato e una eventuale sigla relativa allo status effimero
(avventiziato casuale sensu Viegi et al., 1974) della stazione.
3.4.
Scheda di campo per il rilevamento
floristico
(La versione completa e aggiornata può essere chiesta al
Dr. G. Galasso, Regione Lombardia:
gabriele_galasso@regione.lombardia.it
)
- Albertella A. e Migliaccio F., 2001 – Verifica dati
cartografici per ricerca floristica griglia geografica CFCE. Regione
Lombardia
(rapporto interno).
- Alessandrini A. e Bonafede F., 1996 – Atlante della
flora protetta della Regione Emilia-Romagna. Bologna.
- Bonafede F.,
Marchetti D., Todeschini R., Vignodelli M. e Del Prete C., 1998 – Felci e
piante affini nella provincia di Modena: uno studio preliminare finalizzato
al
monitoraggio ambienatle e alla conservazione della biodiveristà. Provincia di
Modena – WWF Emilia-Romagna – Università di Modena.
- Bonafede F.,
Marchetti D., Todeschini R. e Vignodelli M., 2001 - Atlante delle Pteridofite
nella Regione Emilia-Romagna. Riconoscimento, distribuzione e note
sull’ecologia delle Felci e piante affini in Emilia-Romagna. Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale.
- Brisse H. e Kerguelén
M., 1994 - Code informatisé de la Flore de France. Bulletin de l'Association
d'informatique appliquée à la botanique, Strasbourg, 1: 1-128.
- De Carli
C., Tagliaferri F. e Bona E., 1999 – Atlante corologico degli alberi e degli
arbusti del territorio bresciano (Lombardia orientale). Natura Bresciana 23 –
Monografie – Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.
- Ehrendorfer F.
e Hamann V., 1965 – Vorschlägen zu eimer floristichen kartierung von
Mitteleuropa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. Berlin. 78: 35-50.
- Ferlinghetti R.
e Federici G., 1999 – La cartografia floristica nel Bergamasco: perculiarità,
risultati e tutela ambienatle. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle 51
(1997): 125-134.
- Migliaccio F., 2001. Cartografia tematica e automatica.
Libreria Cluep, Milano.
- Mori A., 1990 – Le Carte Geografiche. Libreria
Goliardica, Pisa.
- Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, 3
Voll.
- Pignatti S., 1994 – La flora. In Pignatti S., 1994 - Ecologia del
paesaggio. UTET, Torino,: 11-55.
- Pirola A., 1998 – Elementi di Botanica.
Regione Lombardia, Manuali delle Guardie Ecologiche – 8.1.
- Poldini L.,
1991 – Atlante corologico delle piante vascolari del Friuli-Venezia Giulia.
Inventario floristico regionale. Regione Friuli-Venezia Giulia. Università
degli Studi di Trieste, Udine.
- Stace C. A., 1991 - New flora of the
British Isles. Cambridge University Press, Cambridge.
- Viegi L., Cela
Renzoni G. e Garbari F., 1974 - Flora esotica d’Italia. Lavori della Società
Italiana di Biogeografia, Forlì, n.s., 4 (1973): 125-220.
Informazioni utili
http://www.regione.lombardia.it/
www.nettuno.it/fiera/igmi/igmit.htm
(sito dell’I.G.M.I.)